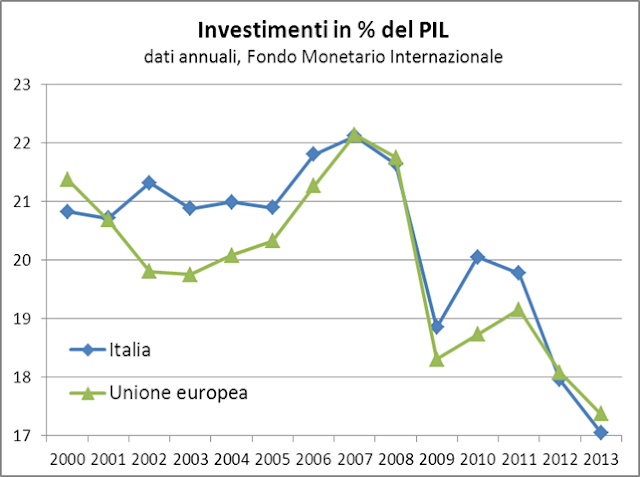Stavo scrivendo un post "tecnico" sul lavoro (sarà un viatico per iniziare bene il 2015...) quando, girellando un po' su Facebook - che non amo (mi perdoneranno gli amici che ho su FB) perché molto spesso è una sentina di livore ed autorazzismo, pieno, se va bene, di facciamoqualcosismo e bisognaunirsituttiperlaPatria (salvo dividersi poi ferocemente per un pur minimo diverso "credo" sovranista), se va male di vimeritatetutto e sietedeirivoluzionaridatastiera (gli altri, naturalmente) - girellando, dicevo, mi sono imbattuto, prima nella proposta lanciata da Scenari Economici di candidare il buon Rinaldi a Presidente della Repubblica (hai il mio voto, Antonio!), pieno di commenti del tipo "magari, ma gli italiani sono pecoroni e pigri e menefreghisti e cinici, quindi è tutto inutile", poi nel post di Arlette Zat che riportava un post di Bagnai con una frase meravigliosa che probabilmente conoscerete, ma che riporto per quei pochi che ignorano Goofynomics:
"Noi avremmo il diritto di sbattercene dell'economia, come della medicina, o della botanica. In una democrazia normalmente costituita dovrebbero essere i politici a doverla capire, l'economia, per indirizzare il paese secondo il mandato politico ricevuto dagli elettori. Non starebbe agli elettori farsi carico di conoscere tutto lo scibile, la Repubblica dei filosofi non esiste perché non può esistere, la funzione alta della politica dovrebbe proprio essere questa, questo tipo di mediazione culturale."
Successivamente ho letto la domanda secca di uno che, rivolgendosi agli "economisti" (che sono ormai le moderne Sibille), chiedeva in pratica "glie 'a famo?" con conseguenti risposte/commenti del tipo "siamo spacciati", condite dal solito "colpa di chi non si informa e vive serenamente beato e italianimerdesimeritanotutto" (scritto probabilmente da un Pari inglese...).
Non so a voi, ma a me l'insieme di questi elementi mi ha spinto ad una riflessione: la democrazia è faticosa. A questa si è collegata una seconda, un tantino meno ovvia: la democrazia non è compatibile con un capitalismo di tipo liberista.
Questa seconda affermazione, mi direte, non è nuova: già J.P. Morgan, in un suo paper aveva chiarito che le Costituzioni democratiche dei Paesi del Sud Europa, nate dalle lotte contro la dittatura, erano incompatibili con l'applicazione di politiche liberiste "pure" come quelle che vuole implementare la UEM; la differenza però è in un non trascurabile dettaglio: non una democrazia di impianto sociale/socialista è incompatibile, ma la democrazia tout court. Che è un bel passo avanti.
Partiamo però dalla prima questione: la democrazia è faticosa, perché presuppone una coscienza ed una capacità di comprensione che solo una formazione culturale solida di base dà e obbliga ad interessarsi di quello che accade al di fuori del nostro vissuto quotidiano. Il primo punto spiega anche perché la democrazia non è esportabile, come fosse un pacco regalo, a Paesi che per il loro percorso storico non hanno ancora una sufficiente alfabetizzazione di massa o comunque le condizioni socio-culturali per svilupparla: la democrazia è una pianta che ha bisogno di trovare il terreno adatto. Ma non basta. La pianta va innaffiata con la partecipazione collettiva, quella che viene chiamata opinione pubblica, che permetta di valutare le scelte politiche ed indirizzare tali scelte con il voto consapevole.
Qui però sorge il problema: se un cittadino ha legittimamente il diritto di non essere un esperto di economia, di diritto, di non essere un filosofo, come dice giustamente il professor Bagnai, perché dovrebbe darsi la pena di essere informato, che già ha il suo lavoro che lo impegna e tanti altri pensieri per la testa? Perché la democrazia rappresentativa, come descritta dal noto economista, forse sta mostrando dei limiti invalicabili e per salvarci dobbiamo faticare di più
Il discorso di Bagnai è teoricamente corretto, ma presuppone che vi sia una categoria di cittadini, i politici, che, delegati appunto dal popolo a curare gli interessi della Nazione, lo facciano con dedizione, altruismo, capacità ed onore (questo riecheggia non a caso il contenuto dell'art. 54 Cost. "I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore"). In altre parole tali cittadini (primi inter pares) dovrebbero studiare e capire le materie di cui sopra, per decidere cosa è meglio per il popolo. Si dirà: ma non devono diventare dei tuttologi, ci sono i tecnici, ovvero gli esperti, i quali dovranno fornire gli strumenti, già elaborati, per poter decidere. Giusto, ma come si può giudicare un parere tecnico, senza avere almeno dei rudimenti della materia, magari per contrastare un certo parere? Vedete, è il problema che hanno nel processo i Giudici con i consulenti tecnici, quando devono decidere: mi affido totalmente e con fiducia alle conclusioni del perito (e quindi decido secondo il SUO parere), o cerco di capire il contenuto della perizia, magari perché ci sono dei punti critici e non condivisibili (e decido secondo il MIO parere)? Un vecchio brocardo definisce il Giudice "peritus peritorum" e questa è/dovrebbe essere la linea prevalente: il magistrato è il "perito dei periti" e sta a lui l'onere e l'onore di decidere se conformarsi o meno al risultato della perizia, naturalmente motivandolo.
Anche il politico quindi e a maggior ragione, dovendo decidere dell'interesse di tutti, non di poche parti, dovrebbe essere un peritus peritorum e voi capite la difficoltà in una realtà estremamente complessa come l'attuale. Questa difficoltà tra l'altro è ciò che ha portato negli anni '80 ed ancor più oggi al mito del "governo tecnico" caldeggiato, come sempre, dai liberisti: se il politico non ci arriva e vede solo il suo interesse privato e quello delle clientele ad esso legate, allora che vadano a governare i "tecnici", scevri da ogni interesse politico-elettorale, che sanno cosa bisogna fare e possono, appunto per la loro neutralità, agire senza condizionamenti. Per la critica a questo pensiero, soprattutto per la dimostrazione della "fallacia dell'ottimo economico" vi rimando al libro di Bagnai, appena uscito, "L'Italia può farcela"; qui ci limiteremo a dire che la politica ha una funzione inalienabile di indirizzo che deve essere preservata. Ma per preservarla occorre che i politici siano preparati e mediamente colti, ovvero che vengano scelti con criteri di merito e capacità. E qui il sistema democratico rappresentativo mostra già dei limiti. Sono ormai decenni che la classe politica scelta o imposta ai cittadini o non è all'altezza del suo compito o tradisce il mandato popolare, per interessi di una sola parte, di solito chi paga la campagna elettorale e può garantire una lunga carriera (ed un bel posto alla fine del mandato).
Si è quindi creata una classe di "ottimati" tanto radicata, quanto incapace o collusa, che di fatto ha reso un mito la rappresentanza delegata, quella per cui si scelgono via, via le persone più capaci e ci si affida al loro governo, buttando solo un occhio di tanto in tanto su quello che fanno, pronti a punirli con il (mancato) voto alle prossime elezioni. Forse non è mai stato così, questa è evidentemente una favoletta, ma per lo meno si tendeva almeno nelle dichiarazioni a questo ideale. Ora ci dicono che chi pone dei dubbi sullo splendido e progressivo percorso attuato dal Governo è un gufo...
Quindi ricapitolando una democrazia rappresentativa che funzioni presuppone una doppia fatica: quella dei politici ad essere pronti e preparati a gestire la Res Publica, con un'attenzione all'interesse collettivo e quella dei cittadini di controllare che ciò venga fatto bene e appunto nel loro interesse. E' possibile attualmente? Probabilmente no, e comunque, qui è il limite invalicabile, se e solo se ci raccontano le cose come stanno, ovvero ci permettono di farci un'idea corretta, senza dover diventare noi stessi dei segugi della notizia e degli esperti dello scibile umano. E qui ci vorrebbe un saggio solo sul problema dell'informazione, per il quale, oltre alla lettura e visione di questo post di Marcello Foa, posso solo rimandarvi ad un altro aspetto interessante da me trattato, ovvero il paradosso della troppa informazione.
Ecco dove la democrazia rappresentativa mostra di essere purtroppo fuori dal nostro tempo: essa presuppone una specie di "patto sociale" duplice, da una parte che i politici delegati non tradiscano il popolo che li ha eletti e non li conducano alla distruzione per interessi altri e magari stranieri (fischiano le orecchie, senatore Monti?), dall'altra, visto che i politici sono uomini e non angeli, che i mezzi di informazione facciano realmente il loro lavoro, che sarebbe quello di dare notizie, possibilmente vere, e non opinioni e veline di spin doctors, così da permettere alla gente, senza troppo impegno e studio, di farsi una corretta opinione ed esercitare il diritto di giudizio e scelta, tramite il voto (ed infatti si dovrebbe poter votare, vero Renzi?). Un patto questo che evidentemente non sussiste più e forse non ha più le condizioni per sussistere.
La soluzione? Io non la so, ma i liberisti ne hanno una ottima come dicevo: cavalcare l'onda ed abolire del tutto la democrazia, prima informalmente, tramite continue scelte "emergenziali" e "necessitate" (che, purtroppo, impongono tempi rapidi e decisioni che non possono aspettare il compimento di iter democratici, lunghi e laboriosi...), poi, quando la rana-popolo è abbastanza bollita da considerare l'emergenza vera o presunta la normalità (notato quanti bei decreti leggi rapidi e spediti fanno gli ultimi governi, senza uno straccio di reale urgenza e necessità, nel silenzio imbambolato o peggio complice dell'opinione pubblica "colta"?), anche formalmente, per esempio abolendo una Camera.
Una vera democrazia presuppone una serie di check and balance (controllo e bilanciamento fra poteri) il più importante dei quali è il voto consapevole e libero del popolo. Ma un popolo consapevole magari non si fa spolpare per ripagare debiti esteri neanche propri e magari si fa due conti su come viveva prima e dopo l'avvento salvifico dell'euro e, sempre magari, si fa una sonora risata in faccia al Plateroti di turno che evoca il costo della benzina come quello dell'uranio se si esce dall'Eurozona (spero che le "pillole rosse" di questo blog le abbiate lette...). Ecco tutto questo da un po' fastidio a chi vuole manovrare liberamente, dentro e fuori l'Italia e siccome la formazione e soprattutto la curiosità di sapere si impara a scuola, ecco che la scuola magicamente va a picco e, a volte letteralmente, in macerie. Come dice quello bravo, tout se tient...
No, decisamente per alcuni la democrazia è fastidiosa e deleteria, un cancro da estirpare, cominciando con l'avvelenarne le radici, ovvero la Costituzione. Spero che, se mi avete letto fino ad oggi, lo abbiate ormai ben chiaro in mente.
Buon 2015.